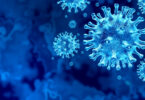18 Settembre 2024 ![]()
Gli istituti penitenziari, luoghi complessi e spesso con alti tassi di sovraffollamento, rappresentano una delle realtà dove i detenuti hanno subito più di tutti le conseguenze del Covid-19, dai contagi fino all’isolamento imposto dalla pandemia. Ne parliamo con Sandro Libianchi, Presidente dell’Associazione “Co.N.O.S.C.I.” (Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane – www.conosci.org) , già dirigente medico nel complesso poli penitenziario di Rebibbia, Roma, specialista in Medicina Interna, Endocrinologia e Farmacotossicologia.
Cosa significa innanzitutto “vivere in carcere”?
Partiamo dal presupposto che ci stiamo riferendo ad un contesto particolare, che è confinato per sua definizione, poiché il ‘sistema-carcere’ intrattiene dei rapporti “controllati” con il resto del mondo; ciò vuol dire che il carcere ha un suo equilibrio del tutto particolare e spesso poco connesso con la realtà esterna, sebbene il “modello carcere” dovrebbe essere un modello di restituzione dell’individuo alla società esterna dopo un processo di riequilibrio. Parliamo dunque di “rieducazione” della persona, ma questo equilibrio è molto instabile poiché spesso il carcere resta ancora più un “contenitore di disagio”. Per questo la mission delle strutture penitenziarie dovrebbe realizzare una conversione da un modello puramente contenitivo ad uno di captazione e restituzione alla società, anche attraverso un giusto riallineamento degli attori in gioco: sanitari, direzioni, Polizia penitenziaria, ASL, ecc. In definitiva, l’occasione della carcerazione dovrebbe rappresentare anche quella del disinnesco delle tensioni individuali negative e una giusta canalizzazione verso una restituzione alla società “sana”. A seguito di una condanna la persona viene messa in carcere ed isolata da tutto: questo è un fatto comunque negativo e facilita processi di regressione dell’individuo. Il carcere diventa un contenitore di disagio psicologico e psichiatrico molto forte: il rischio è che, se l’intervento di sostegno non è adeguato, si assiste ad un peggioramento delle performance individuali. Ciò ha sviluppato grandi tensioni e l’innesto di questa “bomba sociale” interna è scaturito soprattutto dalle tensioni derivate dalla pandemia.
Quali sono, ad oggi, le maggiori problematiche che si riversano sulle carceri italiane proprio come conseguenze della pandemia?
Viviamo una fase che, per sue caratteristiche, non ha sicuramente favorito alcuna tranquillità del sistema, ma anzi ne ha indotto la crisi. Come tutte le realtà complesse, se noi cerchiamo di dare una spiegazione al problema, guardandolo da più angolazioni, non possiamo non considerare il lato sanitario, sfociato addirittura in rivolte. I 12 morti che si sono contati nel marzo scorso ne sono l’esempio drammatico: un fatto del genere non accadeva dagli anni ‘70. La rivolta vera e propria, sistematica, in più carceri, è stato un evento eccezionale, che deve essere considerato adeguatamente. L’altro tema che ha generato malessere è stato il fatto di limitare i contatti con i familiari: questo ha sicuramente aumentato le ansie interne tra i detenuti, anche se poi è scattato una sorta di meccanismo di compenso con le videochiamate, ma di certo non si è risolto il problema ed anzi si è acuito non poco quel senso di isolamento tipici di chi vive in carcere. Inoltre l’organizzazione sanitaria italiana ancora risente della forte distanza tra le necessità percepite o reali e l’offerta sanitaria: questo problema purtroppo viene ancora adesso delegato a dirigenze aziendali lontane, anche fisicamente, dalla struttura carceraria e questo induce una cattiva valutazione delle criticità quotidiane. Ci sono dirigenze sanitarie mediche che ritengono di gestire questi problemi comodamente dalla poltrona del loro ufficio, evitando di ‘sporcarsi le mani’; questo appare come un chiaro indicatore di una sottovalutazione del problema, che resta invece molto complesso. Peggiori sono anche quelle situazioni in cui si considera il carcere come un qualsiasi ambulatorio del territorio dove la cittadinanza riceve diagnosi e cura, ma così non è e questo testimonia la frequente non conoscenza della situazione, laddove lo stato di detenzione crea nuove esigenze e la necessità di risposte organizzative peculiari.
E per il personale sanitario? Quali problematiche ha aggiunto il Covid-19?
I problemi sono diversi e numerosi: diversi per natura, a fronte di una generale carenza di personale sanitario, che riflette anche la carenza nazionale, nelle carceri è ancora maggiore perché questi luoghi non vengono considerati come un “terreno attrattivo” da un punto di vista di sviluppo professionale; è un po’ visto come un “terzo mondo” e chi lo vive ogni giorno o è molto convinto di quello che sta facendo, quindi molto sensibile per natura, oppure ci si ritrova per ripiego: alla base, quindi, c’è una problematica motivazionale. Un altro grande problema è quello della formazione: è veramente sottovalutata, anzi spesso ci troviamo davanti a dei neolaureati o neoassunti, che ricoprono degli incarichi nelle carceri molto delicati, come il medico di guardia, d’emergenza, ma non sono stati forniti di alcuno strumento formativo adatto o minimo. La formazione è fondamentale: dovrebbe essere interprofessionale ed interistituzionale e le diverse figure professionali coinvolte dovrebbero quindi dialogare insieme, interfacciarsi, confrontarsi e formarsi con una procedura “bidirezionale”. Una formazione reciproca permetterebbe uno scambio di esperienza e visione, che ad oggi non c’è o è scarsissima. Paradossalmente questo approccio era più presente in passato, mentre oggi incredibilmente è quasi scomparso. A tal proposito come associazione “CO.NOSCI” stiamo varando un programma nazionale di formazione, che contempli tutto questo, mettendo a confronto i diversi attori in gioco (Sanitari, polizia, direzioni, volontariato, ecc). Un altro aspetto riguarda i contratti: le persone trasferite dal ministero della giustizia alle Asl hanno purtroppo mantenuto il vecchio contratto che avevano fino al 2008, che era un contratto considerato un po’ “scarso”; le Regioni raramente hanno convertito questi contratti, nonostante ciò fosse indicato dalla legge. Infine la “vision” del sistema carcere-salute è molto spostata sulla frammentazione delle competenze, che risulta non organica e non considera la persona come un unicum. La conseguenza è quindi che la visione del sintomo prevale su quella della persona ad onta di precise indicazioni contenute in alcuni accordi in Conferenza Stato-Regione. Ci vorrebbe certamente più empatia, ma parliamo di un sentimento bilaterale: un operatore lasciato solo in carcere, senza una preparazione adeguata e senza un adeguato sostegno aziendale, è raro che riesca ad avere un atteggiamento empatico. Di certo è una caratteristica necessaria, ma purtroppo non frequente. La paura, la non preparazione, giocano a sfavore di un atteggiamento empatico, che è invece necessario per avere un rapporto lineare con la persona detenuta.
Quanto la cultura è di supporto all’interno delle carceri? Cultura è sinonimo di salute?
Sicuramente sì. La parola “cultura”, contestualizzata nel mondo del carcere, può essere declinata ed interpretata in tante forme diverse: un primo tema riguarda la formazione professionale, poi il tema di lavoro, che in carcere esiste ed è fondamentale per supportare e migliorare lo stato di salute mentale e sociale dei detenuti. Cultura vuol dire anche poter coltivare la propria religione, il proprio credo: in Italia esistono tante espressioni religiose ed in carcere è lo stesso. A tale proposito ricordo che la religione musulmana è la seconda più presente nelle carceri italiane ed è quella che maggiormente viene supportata. In alcuni spazi di detenzione viene autorizzato il possesso di immagini ed oggetti sacri. Altra attività culturale molto importante è la biblioteca, che in carcere è sempre presente e rappresenta un luogo molto significativo: sarebbe importante seguire i detenuti in questo percorso perché molti di loro hanno un livello culturale poco elevato, la lettura quindi è spesso non agevole. Poi ci sono i giornali e la televisione, ma vengono anche portati avanti progetti ed attività ludico-ricreative che aiutano queste persone da un punto di vista di benessere: dal gioco degli scacchi, allo sport, fino alle, seppur rare, visite guidate nei musei all’esterno; consideriamo che per un gruppo di detenuti non è un’operazione facile, per tutti i connotati di sicurezza che richiede l’organizzazione di un’attività come questa, in concomitanza di un parere favorevole dei magistrati di sorveglianza. In generale la valutazione dell’effetto benefico di queste attività non è semplice da fare, ma ci sono delle osservazioni dirette che mostrano quanto la conflittualità possa diminuire all’accrescere delle attività culturali.